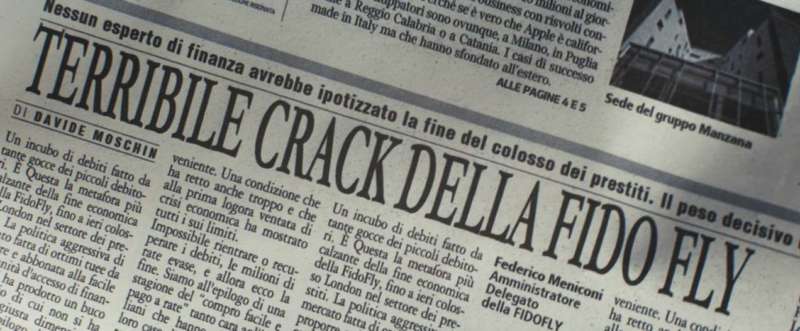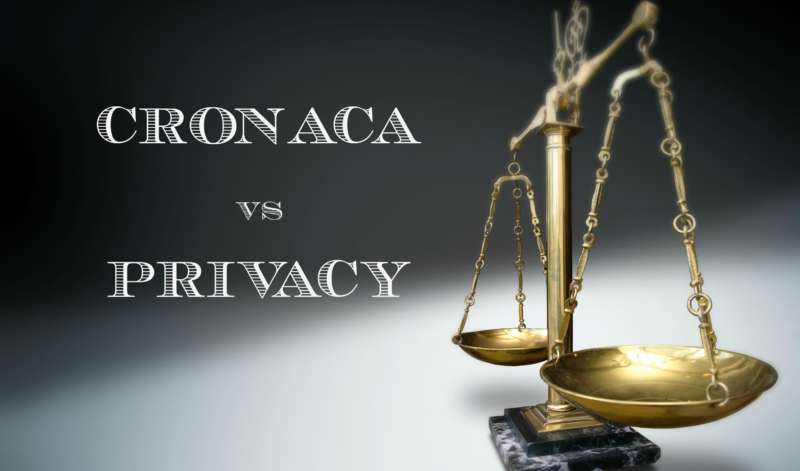La sentenza della Cassazione Sez. VI del 9 dicembre 2020 n. 442 (depositata l’8 gennaio 2021) si rivela estremamente interessante, perché affronta uno dei nodi principali della riforma del reato di abuso d’ufficio introdotta con la legge 11/9/2020 n. 120, che ha sostituito le parole “norme di legge e di regolamento” con quelle di “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La vicenda da cui trae origine la pronuncia in commento riguarda un commissario straordinario e direttore generale di un’azienda ospedaliera, al quale veniva contestato il reato di abuso d’ufficio, perché con delibera del 22/12/2010 aveva illegittimamente dequalificato il servizio di prevenzione e protezione da struttura complessa a struttura semplice, depotenziando la posizione giuridica ed economica del suo direttore e privandolo dell’indennità di posizione.
Sia in primo che in secondo grado i giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di abuso d’ufficio, perché, in assenza di urgenti esigenze riorganizzative dell’azienda, aveva destrutturato l’organigramma dell’azienda al fine di danneggiare la posizione economica del direttore della struttura complessa.
A seguito di ricorso per Cassazione promosso dall’imputato, la Suprema Corte, nonostante la constatata estinzione del reato per prescrizione, si è interrogata sulla reale portata innovativa della riforma e sulle conseguenti problematiche di diritto intertemporale relative alle condotte abusanti poste in essere in precedenza.
Alla luce della nuova riforma, secondo gli Ermellini, in luogo del generico richiamo della previgente disciplina alla indeterminata violazione “di norme di legge o di regolamento“, si pretende oggi che la condotta produttiva di responsabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti per l’azione amministrativa, che per un verso siano fissate dalla legge (non rilevano dunque i regolamenti, nè eventuali fonti subprimarie o secondarie) e per altro verso siano specificamente disegnate in termini completi e puntuali.
Di qui il lineare corollario della limitazione di responsabilità penale del pubblico funzionario, qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica: intesa, questa, nel suo nucleo essenziale come autonoma scelta di merito dell’interesse primario pubblico da perseguire in concreto, effettuata all’esito di una ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati.
La nuova disposizione normativa risulta avere, dunque, un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice penale tanto l’apprezzamento dell’inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o subprimario, quanto il sindacato del mero “cattivo uso” – la violazione dei limiti interni nelle modalità di esercizio – della discrezionalità amministrativa.
La distinzione si fonderebbe sulla diversa violazione dei limiti esterni o dei limiti interni della discrezionalità amministrativa, laddove la violazione dei primi (limiti esterni) darebbe luogo alle forme patologiche dell’esercizio del potere discrezionale, mentre laviolazione dei limiti interni si tradurrebbe nel “cattivo uso” di quel potere, estraneo, però, al reato di abuso d’ufficio.
Il tema dei limiti esterni ed interni del potere discrezionale della pubblica amministrazione è estremamente complesso. Ed è difficile fornire un criterio distintivo tra limiti interni o limiti esterni della discrezionalità e tra uso patologico e “cattivo uso” del potere discrezionale per distinguere lo sviamento di potere penalmente rilevante da quelle forme di cattivo uso del potere discrezionale, inidonee ad integrare il reato di abuso d’ufficio.
L’unico criterio di verifica applicabile sembrerebbe essere quello di accertare se la condotta del pubblico agente sia orientata alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere gli è stato conferito.
All’esito di questo ragionamento, la Corte conclude nel senso che la nuova formulazione della fattispecie dell’abuso di ufficio, restringendone l’ambito di operatività con riguardo al diverso atteggiarsi delle modalità della condotta, realizzi una parziale abolitio criminis in relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, che non siano più riconducibili alla nuova versione dell’art. 323 c.p., siccome realizzati mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. Con il lineare corollario per cui all’abolizione del reato, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, consegue nei processi in corso il proscioglimento dell’imputato, con la formula “perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato“.
Dunque, ritiene il Collegio che, alla luce della sopravvenuta modifica normativa, non possa essere confermata l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di abuso d’ufficio in quanto risulta infatti assente nella condotta contestata il dato strutturale nella nuova versione dell’art. 323 c.p. della “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità“. Ed invero, la deliberazione con la quale il commissario straordinario ha proceduto alla dequalificazione a struttura semplice del Servizio Prevenzione e Protezione diretto dalla persona offesa ed al concreto demansionamento della posizione giuridica ed economica di quest’ultima, da Direttore a Responsabile della struttura, non può dirsi emanata in carenza di alcuna finalità di riorganizzazione dell’Azienda ospedaliera. Trattasi, a ben vedere, di un atto di riorganizzazione delle strutture e dei servizi dell’Azienda ospedaliera che, siccome non adottato dal titolare del potere deliberativo in situazione di interessi in conflitto, nè connotato da una oggettiva distorsione dai fini pubblici di buon andamento, efficienza ed economicità perseguiti dallo stesso ente, rientra fra quelle scelte di merito che, nel contesto della discrezionalità amministrativa, la nuova formulazione dell’art. 323 c.p. sottrae al sindacato del giudice penale.
In conclusione, sembrerebbe che, con l’ultima riforma del reato di abuso di ufficio, si sia effettivamente voluto eliminare dal panorama dell’illecito penale l’uso distorto dei poteri discrezionali del funzionario pubblico verso fini privati.
Tuttavia, non è pensabile che il Legislatore abbia inteso legittimare e quindi sottrarre a sanzione penale le forme patologiche che possono caratterizzare l’agire della Pubblica Amministrazione quali il favoritismo affaristico, lo sfruttamento dell’ufficio, la prevaricazione per scongiurare la paralisi dell’attività pubblica, perché altrimenti sarebbe stato più coerente abrogare direttamente il reato di abuso d’ufficio.
Il fatto che il reato di abuso d’ufficio sia stato mantenuto nello statuto penale della Pubblica Amministrazione non può che significare che l’uso distorto del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale verso fini privati non ha perso la sua rilevanza penale.
Ed infatti la Cassazione con la sentenza in commento sembra confermare questa soluzione nel senso di limitare la responsabilità penale del pubblico funzionario, qualora le regole comportamentali gli consentono di agire in un contesto didiscrezionalità amministrativa. Mentre permane la rilevanza penale l’esercizio del potere discrezionale “che trasmodi in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici, c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito; oppure si sostanzi nell’alternativa modalità della condotta, rimasta penalmente rilevante, dell’inosservanza dell’obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi”.
Avv. Elena Daniele