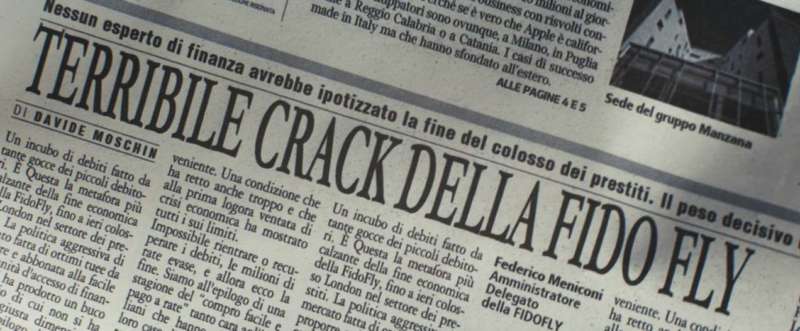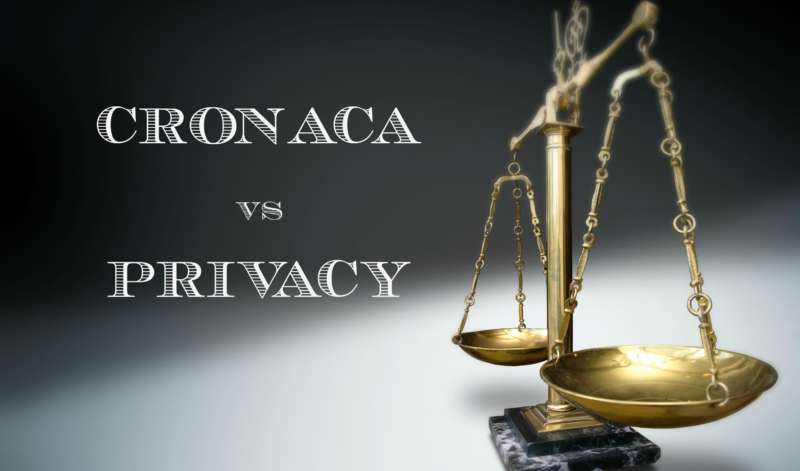Con il D. Lgs. 12.01.2019 n.14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) il Legislatore ha inteso ridisciplinare la materia delle procedure concorsuali, introducendo un impianto organico destinato a fungere da nuovo riferimento per l’intera materia.
Il decreto entrerà in vigore trascorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione in G.U. e, quindi, il 14 agosto 2020. Tuttavia, alcuni articoli[1] sono già entrati in vigore lo scorso 16 marzo.
Il regime originario della Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267), fondato sulla logica della liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore insolvente, ha mostrato da subito evidenti limiti, sussumibili nella tardività dell’apertura della procedura, nella eccessiva durata della stessa, nella difficoltà di salvaguardia dei valori aziendali esistenti e, non da ultimo, nella percentuale minimale di soddisfazione del credito. A partire dal 2006 il Legislatore più volte ha riformato la Legge Fallimentare, introducendo e valorizzando soluzioni negoziali della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, composizione della crisi da sovraindebitamento…) come strumenti più efficienti per la tutela dei creditori, rimanendo tuttavia nel solco della logica “liquidatoria” dell’impianto originario.
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sostituisce sia la Legge Fallimentare del 1942 che le discipline speciali successivamente introdotte, e si pone come disciplina organica di riferimento della materia. Le novità sono molte e sono destinate a rivoluzionare sia la gestione della crisi, sia il momento antecedente la stessa. Vediamo le principali.
In primo luogo, balza subito all’occhio la ratio che ha ispirato il Legislatore ad intervenire in maniera così massiccia su una materia già ampiamente rimaneggiata: si è inteso mitigare il regime sanzionatorio/liquidatorio della procedura di insolvenza dell’imprenditore a favore della tutela degli interessi e dei valori aziendali al fine del recupero della produttività dell’azienda in crisi. L’interesse primario di soddisfacimento dei creditori viene infatti bilanciato con quello della salvezza dei valori imprenditoriali.
Questa volontà si riflette anche sulla terminologia utilizzata: vengono eliminati i termini “Fallimento” e “Fallito”, generalmente connotati da un certo disvalore sociale, a favore del termine “Liquidazione giudiziale”, da intendersi come evento senz’altro da evitare, ma possibile nella vita dell’impresa ed anzi connaturato all’essenza stessa dell’imprenditore quale professionista che, per definizione, accetta il rischio d’impresa.
In quest’ottica, viene introdotta una procedura di allerta (art. 12 e seguenti) che consente all’imprenditore di rilevare i primi indizi di crisi, e quindi acquisire coscienza della salute della società, in un momento in cui sia ancora possibile intervenire al fine del componimento. Si tratta di obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente della ricossione), strutturati nel senso di prevedere una prima informativa all’imprenditore stesso, alla quale, in caso mancata adeguata risposta o di inerzia nell’adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi (nei confronti dei creditori pubblici è necessaria l’estinzione del debito o la presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi o la domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza), farà seguito formale segnalazione agli OCRI (organismi di composizione della crisi di impresa) istituiti presso le Camere di Commercio. Gli OCRI hanno il compito di gestire la fase di allerta e, per le imprese diverse da quelle minori, la fase della composizione assistita della crisi, aiutando l’imprenditore ad individuare le possibili misure per porre rimedio alla situazione.
Viene inoltre ampiamente modificata e rafforzata la disciplina del concordato preventivo (art. 84 e seguenti), teso ora prevalentemente alla ristrutturazione della società: viene infatti privilegiato il concordato in continuità – ovviamente laddove materialmente possibile – a discapito del concordato liquidatorio, che viene sottoposto a maggiori restrizioni rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. Per il concordato in continuità, è previsto che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta (ossia nelle mani dell’imprenditore che ha presentato la domanda) o indiretta (ossia per l’ipotesi in cui l’azienda venga gestita da un terzo in forza di cessione, usufrutto, affitto ecc…). Per il concordato liquidatorio viene invece confermata la soglia minima di soddisfacimento dei crediti chirografari del 20%, ma è previsto l’apporto di risorse esterne tale da incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento di detti crediti, che non può essere in ogni caso inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario (art. 84 co. 4).
Una importante innovazione consiste nel superamento della previgente dicotomia crisi di impresa (imprenditore commerciale non piccolo) / sovraindebitamento del debitore civile (piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, professionista intellettuale, consumatore), a favore di una frammentazione (forse eccessiva) di categorie di soggetti sottoponibili alle diverse procedure, a seconda dell’attività svolta (imprenditore, professionista intellettuale, consumatore), per oggetto dell’attività (impresa commerciale, impresa non commerciale) e per dimensione (impresa minore[2], impresa medio-grande, grande impresa[3]).
Mentre l’imprenditore commerciale non minore è sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale, il debitore diverso può essere sottoposto alla procedura di liquidazione controllata: si tratta di procedure simili tra loro, in quanto condividono la struttura di fondo, ma che si differenziano nella snellezza della seconda, e nel fatto che in questa non sono applicabili gli istituti a presidio del recupero del credito diversi da quelli previsti dal codice civile (es. revocatoria fallimentare).
La frammentazione di cui si è detto emerge con chiarezza in relazione agli strumenti negoziati di regolazione della crisi. Dall’articolata disciplina, si possono ricavare le seguenti “combinazioni”:
- Imprenditore commerciale medio grande: concordato preventivo, composizione assistita della crisi
- Imprenditore commerciale minore: concordato minore, composizione assistita della crisi
- Imprenditore agricolo medio/grande: concordato minore, accordi di ristrutturazione, composizione assistita della crisi
- Imprenditore agricolo minore: concordato minore, composizione assistita della crisi
- Professionista intellettuale: concordato minore
- Consumatore: piano di ristrutturazione del debito
Viene, infine, modificato il codice civile (art. 375 e seguenti): si prevede, tra l’altro, l’obbligo, in capo all’imprenditore, di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 2086 c.c.); gli amministratori sono ritenuti responsabili “verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”, responsabilità che può essere fatta valere quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti (art. 2476 c.c.); vengono previste delle ipotesi di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 2477 c.c.).
Con favore deve senz’altro essere valutato l’orientamento “anticipatorio” del Legislatore, volto alla tempestiva rilevazione dei primi segnali di crisi dell’impresa da parte di soggetti diversi dall’imprenditore, per assicurare un rapido intervento volto alla composizione della crisi, prima che la situazione diventi irrimediabile. Come positiva è la volontà di impattare sulla governance delle società, laddove viene imposto agli amministratori l’obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi e contabili interni.
Se un rilievo può essere mosso, dovrebbe essere indirizzato alla mancata attuazione, prevista dalla legge di delega, della riorganizzazione della competenza a trattare i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza in capo alle sezioni specializzate dei tribunali. Il Codice attua tale regolamentazione solo parzialmente, nella parte in cui attribuisce la competenza al Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa solamente per le imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (art. 27), restando la competenza dei Tribunali ordinari per tutte le altre imprese.
Inoltre, in controtendenza con la giurisprudenza più recente si pone la presunzione di quantificazione del danno che gli amministratori sono chiamati a risarcire in caso di violazione dei loro doveri[4], e ciò a prescindere dall’effettiva dimostrazione, in giudizio, della negligenza in capo all’amministratore.
In conclusione, la riforma, andando a ridisegnare in maniera sistematica ed organica la disciplina della crisi dell’impresa, si pone in discontinuità con i precedenti interventi legislativi, che si erano limitati a modificare la Legge Fallimentare, conservandone l’impianto di fondo. La lunga vacatio legis di 18 mesi, pensata appositamente per “aggiustare” eventuali incongruenze, permetterà di varare tutti i correttivi che in corso d’opera saranno ritenuti necessari, al fine di garantire piena operatività al nuovo sistema. Interventi che, peraltro, appaiono prevedibili.
Sebbene sia senz’altro positivo il cambio di mentalità operato dal Legislatore, nel senso di aiutare l’imprenditore a salvare, per quanto possibile, i valori aziendali piuttosto che regolamentare minuziosamente la pesante procedura di liquidazione fallimentare, solamente l’esperienza ci dirà se ci troviamo di fronte ad una riforma epocale. Una volta saggiatone l’impatto in concreto – e ciò anche in relazione all’approccio che sarà dato dai giudici – si potrà valutare l’efficienza di tale intervento e, nello specifico, l’idoneità dello stesso a fungere da effettivo supporto per l’imprenditore in crisi e volenteroso a salvare la propria azienda.
Avv. Francesco Todeschini
[1] Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.
[2] Attivo inferiore a € 300.000,00, ricavi annui inferiori a € 200.000,00, debiti inferiori a € 500.000,00
[3] Per la quale rimane ferma la disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria
[4] Art. 378 co. 2: <<All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e’ verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”>>