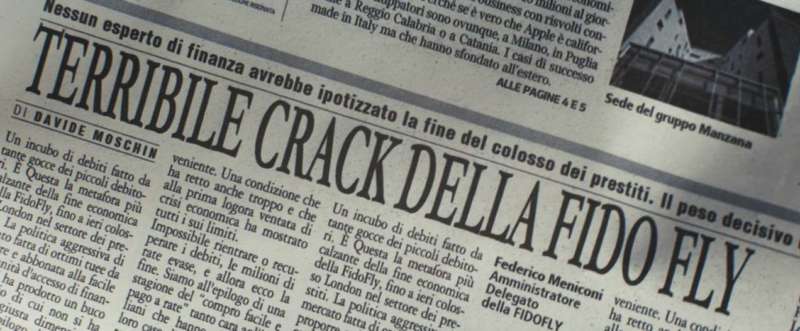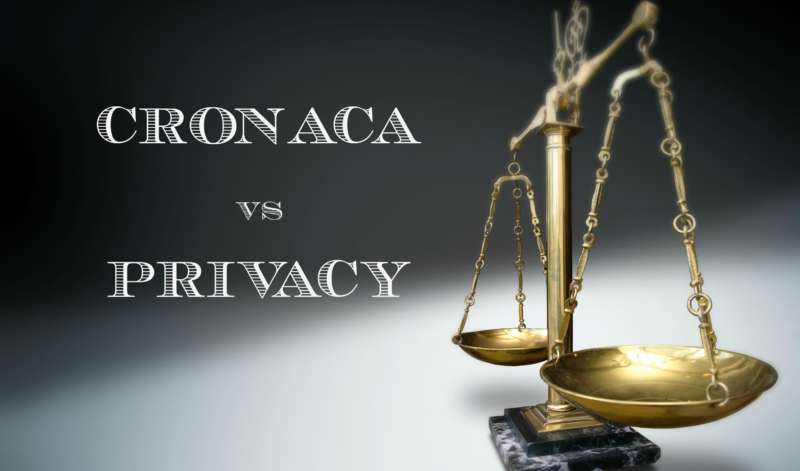La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza dell’11.11.2019 n. 28992, è tornata ad occuparsi dell’onere della prova incombente sul paziente in ipotesi di risarcimento del danno iatrogeno nella malpractice medica.
La Suprema Corte, soffermandosi sul riparto dell’onere della prova, si è chiesta se il paziente che agisce nei confronti della struttura sanitaria e del medico per il risarcimento del danno iatrogeno possa limitarsi ad allegare l’inadempimento ovvero abbia l’onere di provare l’aggravamento e/o l’insorgenza di una nuova patologia e il nesso di causalità tra questo evento e la condotta concreta del medico.
Sino al 2018, infatti, valevano i principi sanciti dalla celeberrima sentenza a Sezioni Unite 13533/2001 in tema di allocazione dell’onere probatorio e della “vicinanza della prova”. Infatti, nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, il paziente (creditore della prestazione risarcitoria) era tenuto a: provare il titolo contrattuale, allegare l’inadempimento del medico e della struttura nel suo complesso e il fatto che esso sia stato eziologicamente rilevante per la produzione del danno-evento. Infine, sul paziente incombeva l’onere di provare i danni-conseguenza subiti a causa dell’altrui illecito.
Sull’onda del suddetto orientamento giurisprudenziale, sempre la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU 577/2008) aveva sancito che: «nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell’onere della prova, l’attore ha il solo onere di allegare e provare l’esistenza del contratto, e di allegare l’esistenza di un valido nesso causale tra l’errore del medico e l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che l’inadempimento non vi è stato, ovvero che esso, pur essendo sussistente, non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall’attore». Pertanto, a mente delle Sezioni Unite 577/2008, sull’Ospedale incombeva l’onere di provare o che inadempimento non c’è stato (o che non è stato imputabile) ovvero che, pur essendoci stato, non abbia avuto rilevanza causale nella produzione del danno-evento.
E’ evidente il netto favor di tale giurisprudenza per la posizione del paziente, in quanto il peso dell’onus probandi è chiaramente spostato in capo all’Ospedale.
A partire dal 2018 si è assistito a un progressivo superamento del suddetto orientamento giurisprudenziale. La Cassazione ha chiarito che quando il facere richiesto è di natura professionale non basterà che il creditore si limiti ad allegare l’inadempimento, incombendo sul predetto l’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra evento e danno (cfr. Cass. 13752/2018). L’ordinamento conosce, infatti, due accezioni di “causalità”: da un lato la causalità materiale, che consiste nel nesso eziologico che lega la condotta del debitore e il fatto storico dell’inadempimento; dall’altro la causalità giuridica, che consiste nel nesso causale tra l’inadempimento e le conseguenze dannose – patrimoniali e non – che si producono nella sfera giuridica del creditore. La Cassazione ha quindi specificato che sul paziente non grava più soltanto l’onere di provare il danno conseguenza (ossia la causalità giuridica), come si riteneva sino al 2018, ma grava anche l’onere di provare la c.d. causalità materiale.
Nella responsabilità contrattuale, «la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall’inadempimento per la differenza tra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall’inadempimento, perché quest’ultimo corrisponde all’interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento».
Quando invece il facere richiesto è di natura professionale non basterà che il creditore si limiti ad allegare l’inadempimento, incombendo sul predetto l’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra evento e danno.
Secondo la Cassazione, quindi, i principi che regolano l’onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale non sono suscettibili di applicazione quando l’obbligazione consiste in un facere professionale perché in questo caso l’esecuzione della prestazione è meramente strumentale alla soddisfazione di un interesse presupposto e/o primario, corrispondente al diritto alla salute.
Osserva la Corte, infatti, che «se l’interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all’interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell’interesse alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione, ma della lesione dell’interesse presupposto a quello contrattualmente regolato».
Il medico non si obbliga a garantire la guarigione del paziente, ma – in accordo con la nota distinzione tra obbligazione di risultato e di mezzi – «il perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore».
L’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie è un danno evento che «attinge non l’interesse affidato all’adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute».
Detto altrimenti, sebbene la guarigione non sia l’oggetto dell’obbligazione, la quale invece riguarda l’esecuzione dell’opera professionale secondo le leges artis, la guarigione rappresenta un interesse primario o presupposto rispetto all’interesse strumentale all’esatta esecuzione della prestazione professionale: «non c’è obbligazione di diligenza professionale del medico se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia».
Ciò significa che nessun addebito potrà imputarsi al professionista che abbia eseguito diligentemente la prestazione ma non abbia conseguito il risultato sperato; se invece il professionista non esegue correttamente l’opera per la quale si è obbligato, l’inadempimento potrà avere riflessi sull’interesse presupposto o primario del creditore (e cioè, nella specie, che le sue condizioni di salute non si aggravino), ma in tal caso – perché il professionista risponda nei confronti del paziente – quest’ultimo dovrà dimostrare il nesso di causalità materiale, ossia il nesso eziologico tra l’errore professionale e la lesione dell’interesse primario (la salute).
Una volta allegato l’inadempimento ed accertato il nesso di causalità materiale tra l’erronea prestazione professionale e, in ipotesi, l’aggravamento della patologia, sarà onere del debitore provare o di avere esattamente adempiuto ovvero l’impossibilità della prestazione per fatto a lui non imputabile, ossia l’esistenza di una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua della ordinaria diligenza, e l’impossibilità sopravvenuta di eseguire l’obbligazione con diligenza professionale.
Conseguentemente, se rimane ignota la causa dell’aggravamento della patologia o dell’insorgenza di nuove malattie, la domanda risarcitoria del paziente non potrà essere accolta.
Con la sentenza in esame, quindi, la Cassazione ha operato un ritorno al passato.
La pronuncia dà continuità alla più recente giurisprudenza della Cassazione, chiarendo che le regole sull’onere della prova risalenti alla decisione del 2001, se non richiedono che il creditore dia anche la prova del nesso di causalità materiale – potendo limitarsi ad allegare il solo fatto dell’inadempimento nel quale è assorbita la causalità materiale – valgono laddove l’obbligazione è di dare o di fare, ma non anche quando si tratta di un facere professionale.
La giurisprudenza di legittimità sembra dunque tornare all’orientamento precedente alle Sezioni Unite del 2008. La vera novità, tuttavia, consiste nel chiarire che i principi che regolano l’onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale non sono suscettibili di applicazione quando l’obbligazione consiste in un facere professionale perché in questo caso l’esecuzione della prestazione è meramente strumentale alla soddisfazione di un interesse presupposto e/o primario, corrispondente al diritto alla salute.
Salute, quindi, la cui integrità non è necessariamente compromessa dall’inosservanza delle leges artis ma può dipendere da una causa diversa dall’inadempimento.
Ed è proprio questa causa – ovvero questo collegamento “naturalistico” tra la lesione della salute e la condotta del medico che il paziente deve allegare e provare anche facendo ricorso alla presunzione – che costituisce l’elemento costitutivo della fattispecie, con l’ulteriore conseguenza che la causa rimasta ignota precluderà l’accoglimento della domanda risarcitoria.
In conclusione, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale, il fatto sopravvenuto all’intervento chirurgico può essere considerato caso fortuito se resta ignota, anche mediante l’utilizzo di presunzioni, la causa dell’evento di danno; le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore, invece, se resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l’imprevedibilità e inevitabilità di tale causa.
di Beatrice Bellato