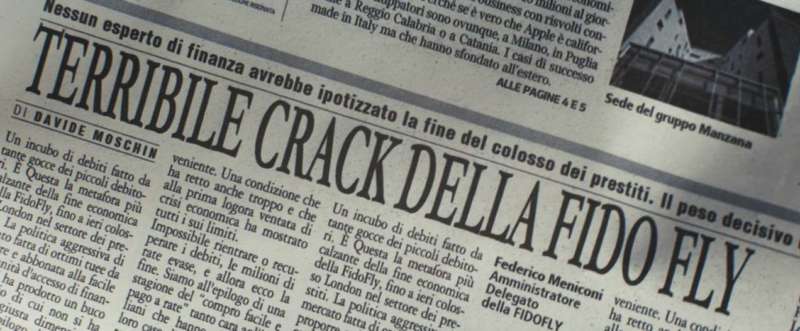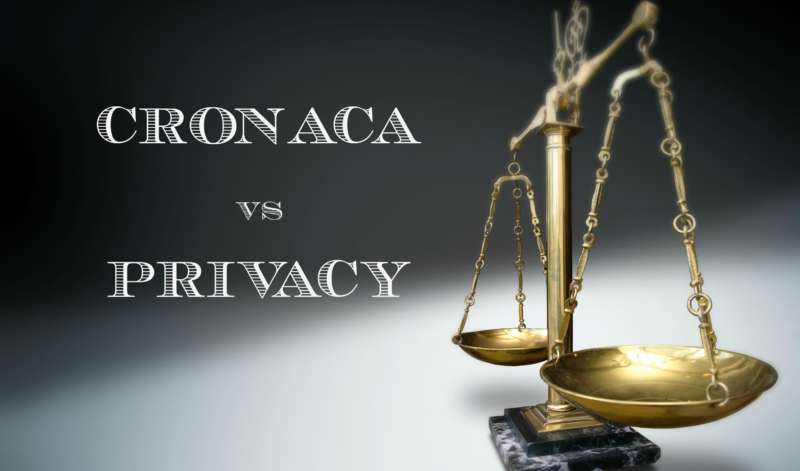Una delle principali novità introdotte dal legislatore con il Codice dell’impresa e dell’insolvenza – la cui entrata in vigore è stata di recente posticipata all’1.09.2021 – consiste nell’istituzione di strumenti di allerta che consentano di rilevare, in tempi rapidi, una situazione di crisi che possa condurre all’insolvenza, sul presupposto che un intervento che impatti precocemente e tempestivamente sull’andamento dell’azienda ne aumenti le probabilità di evitare di dover accedere a procedure di risanamento aziendale.
Tale intervento si traduce nell’introduzione di specifici obblighi di segnalazione, previsti dall’art. 12 CCI, posti a carico di determinati soggetti indicati negli artt. 14 e 15 CCI. Tali sistemi di allerta, nell’intenzione del legislatore concorrono a formare gli assetti organizzativi di cui l’impresa deve dotarsi ai sensi dell’art. 2086 c.c. il quale, nella novella introdotta dall’art. 375 CCI, prevede che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale “.
Ciò significa che gli assetti organizzativi già utilizzati dalle imprese vengono oggi indirizzati anche alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi dell’impresa, al fine di tutelarne la continuità aziendale. Gli organi di controllo, nonché il revisore contabile (o la società di revisione), dovranno dunque vigilare che l’amministratore ponga in essere un assetto organizzativo che sia idoneo alla rilevazione dei segnali di crisi, e che adotti tutte le misure necessarie non appena questi si manifestino.
Scopo degli obblighi di segnalazione è quindi quello di mettere l’imprenditore nella condizione di poter essere prontamente avvisato dall’organo di controllo (collegio sindacale, revisore contabile, società di revisione) ovvero da determinati creditori pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione) del manifestarsi dei primi sintomi della crisi d’impresa, al fine di adottare il prima possibile le necessarie contromisure. E’ infatti del tutto verosimile che un “occhio” esterno all’impresa abbia maggiore capacità, rispetto all’imprenditore, di cogliere determinati segnali.
Tale meccanismo funziona su più livelli. Se l’imprenditore si è dotato di adeguati assetti organizzativi, questi sarà consapevole del manifestarsi dei primi indizi di crisi già prima che vengano rilevati dall’organo di controllo nel corso delle verifiche periodiche. Di contro, un adeguato sistema di controllo interno dovrebbe rilevare gli indizi della crisi ben prima che ciò venga fatto dai creditori pubblici, i quali intervengono nella segnalazione in ipotesi di ritardi dei pagamenti dei tributi e dei contributi di notevole entità. E’ dunque agevole ritenere che, in caso di segnalazione da parte dei creditori pubblici, qualcosa abbia ha funzionato nella “catena” inferiore di rilevazione, vuoi per il difetto di adeguati sistemi organizzativi, vuoi perché l’imprenditore ha deciso di ignorare i segnali emersi.
Gli indicatori della crisi vengono individuati dall’art. 13 co. 1 CCI in squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici, ovvero in reiterati e significativi ritardi nei pagamenti delle obbligazioni.
Quanto agli indici di allerta, idonei a rilevare i detti squilibri, essi devono dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Il co. 2 prevede che i detti indici debbano essere determinati ogni due anni dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Essi dovranno tenere conto, come previsto dalla norma, della specifica attività esercitata dall’impresa e alle specifiche caratteristiche della stessa, in modo tale da essere adeguati alla struttura economica dell’azienda. A ciascun tipo di attività produttiva corrisponderanno dunque dei diversi indici di allerta.
E’ altresì possibile, a norma dell’ultimo comma dell’art. 13, che vengano elaborati degli indici personalizzati per la singola impresa, qualora si ritengano non adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC. Si avrà in tal modo una sorta di disapplicazione degli indici individuati a livello nazionale a favore dell’applicazione di indici personalizzati e rapportati alla specificità dell’impresa. In tale ipotesi si dovrà motivare, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, la mancata adozione degli indici elaborati dal CNDCEC, e si dovranno indicare nella medesima nota, gli indici adottati, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente.
Quanto ai ritardi nei pagamenti dei debiti aziendali, che debbono essere considerati alla stregua di uno specifico e diverso warning rispetto agli “squilibri” di cui alla prima parte del medesimo art. 13 co. 1 e i relativi indici di rilevazione, viene in rilievo il dato temporale previsto dalla norma in parola: deve trattarsi di ritardi “reiterati e significativi”, considerato anche quanto previsto dall’art. 24 CCI.
Quest’ultimo articolo prevede un meccanismo premiale per l’imprenditore che acceda ad una delle procedure di composizione della crisi regolate dal codice entro il termine di sei mesi da quando si verifica, alternativamente: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (oltre che una terza ipotesi che qui non interessa). Ecco dunque che il ritardo qualificato nei pagamenti di cui all’art. 13 CCI andrà ricondotto ad una di queste due ipotesi normativamente previste.
Ci si può domandare se possano essere considerati indizi della crisi anche reiterati e significativi ritardi nei pagamenti diversi da quelli previsti dall’art. 24 CCI. La risposta non può che essere affermativa, ritenendo una lettura eccessivamente rigida ed ancorata a parametri standardizzati non coerente con la finalità sottesa alla riforma della crisi dell’impresa.
Da ultimo, un cenno va fatto in merito ai soggetti obbligati alla segnalazione e al relativo regime sanzionatorio per l’ipotesi di omissione. Già si è detto come si debba distinguere tra i sistemi di allerta interni (organo di controllo contabile) ed esterni (creditori pubblici) .
I primi, ai sensi dell’art. 14 CCI, sono tenuti a verificare che l’amministratore valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società e l’idoneità dello stesso a far emergere gli indizi dell’eventuale crisi, e a segnalare immediatamente allo stesso amministratore l’esistenza dei detti indizi. La segnalazione, che deve essere motivata, va fatta per iscritto all’amministratore, il quale avrà un termine non superiore a trenta giorni per rispondere, indicando le iniziative che intende adottare per il contenimento e il superamento dello stato di crisi. Dette misure debbono poi essere adottate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In ipotesi di mancato riscontro, ovvero mancata attuazione nel termine delle iniziative prospettate, l’organo di controllo effettuerà formale segnalazione all’OCRI competente.
Qualora l’organo di controllo ometta di effettuare la segnalazione, pur essendovi tenuto, non potrà beneficiare del meccanismo premiale previsto dal comma 3 dell’art. 14 CCI per l’ipotesi di tempestiva segnalazione, consistente nell’esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli che venissero poste in essere dall’organo amministrativo successivamente alla segnalazione, purchè venga fatta la segnalazione all’OCRI. Si tratta dunque di un meccanismo di incentivazione che non prevede l’applicazione di misure coercitive o sanzionatorie per l’ipotesi di inerzia, bensì, al contrario, prevede il riconoscimento di beneficio di non poco momento per l’ipotesi di attivazione, consistente nello “scarico di responsabilità” sull’organo gestorio.
Diverso è il discorso riguardante i creditori istituzionali (INPS, Agenzia entrate, Agente della riscossione): per questi l’art. 15 CCI prevede, per l’ipotesi di inerzia, una sanzione – piuttosto pesante – consistente nella perdita del privilegio sui crediti vantati nei confronti del debitore.
Encomiabile è lo sforzo del legislatore nell’apportare un meccanismo innovativo di ausilio all’attività imprenditoriale nell’ottica di prevenire possibili dissesti aziendali. Non è mancato, tuttavia, chi ha sottolineato i punti deboli del sistema degli assetti organizzativi e ciò, in particolare, nella forse eccessiva discrezionalità degli indici di allerta, peraltro derogabili dall’imprenditore attraverso la personalizzazione degli stessi, e nel sistema di esonero di responsabilità dell’organo di controllo che si sia tempestivamente attivato nella segnalazione di cui all’art. 14. Lo “scarico di responsabilità”, infatti, potrebbe portare da un lato ad una eccessiva prudenza dei revisori, con conseguente innesco del relativo iter procedimentale in situazioni evitabili e, dall’altro, ad una eccessiva deresponsabilizzazione dei medesimi proprio nel momento in cui al contrario vi sarebbe maggiore necessità di un intervento rigoroso.
Avv. Francesco Todeschini