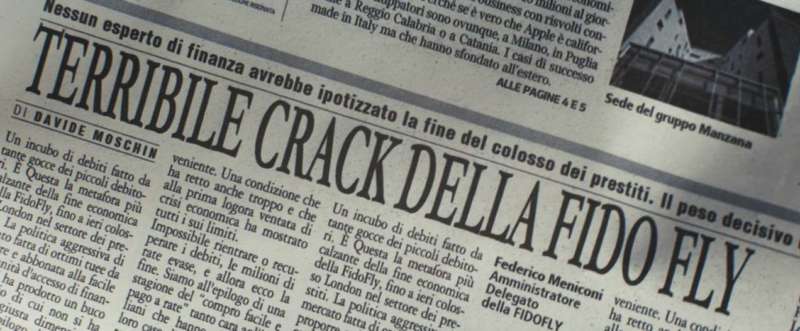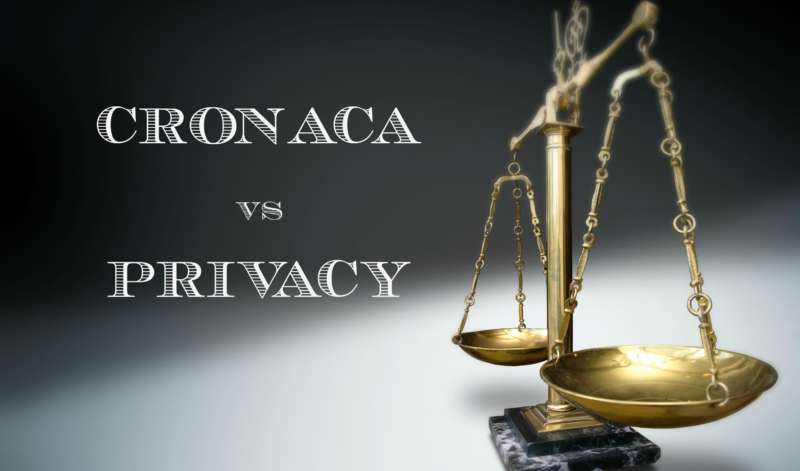Quali diritti per il viaggiatore che annulla il viaggio a causa del Coronavirus?
Numerosi sono i cittadini italiani che, spinti da esigenze lavorative o al fine di godersi un piacevole
soggiorno, in tempi non sospetti, antecedenti al diffondersi della pandemia da COVID-19, avevano
acquistato un cd. pacchetto turistico o stipulato un contratto di trasporto (aereo, marittimo o
ferroviario).
Tuttavia, com’è noto, le misure governative ad oggi emanate in ottica di contenimento del contagio
hanno vietato gli spostamenti, sia all’interno del territorio nazionale sia verso altri Paesi,
conseguentemente non permettendo al viaggiatore di godere del servizio acquistato.
Viene quindi spontaneo domandarsi quali siano – e se esistano – i rimedi esperibili dal
consumatore onde ottenere tutela dei propri diritti nei confronti dell’operatore di viaggio: il primo
potrà ottenere dal secondo la restituzione delle somme corrisposte per il godimento di un servizio
la cui erogazione è stata resa impossibile da un provvedimento della Pubblica Autorità?
Giacché lo scenario normativo sul punto si rivela complesso e apparentemente contraddittorio,
occorre effettuare una chiara analisi dei principi applicabili al caso di specie, così da rispondere al
quesito testé esposto.
1. La previsione del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020
In primo luogo sarà bene analizzare le previsioni rese, al riguardo, proprio nell’ambito delle misure
emergenziali emanate per limitare la libertà di circolazione dei cittadini e, in particolare, le
disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 9, datato 2 marzo 2020.
In particolare, la disciplina del caso di specie si rinviene nell’art. 28 del citato decreto, rubricato –
per l’appunto – “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”, il quale elenca, al co. 1, tutte le
specifiche situazioni relative ai contratti “di trasporto aereo ferroviario, marittimo, nelle acque
interne o terrestre”, rispetto alle quali “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione”, ricomprendendo in esse, expressis verbis,
tutte le circostanze nelle quali, a cagione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da
Coronavirus, il viaggiatore non possa godere della prestazione dell’operatore o quest’ultimo non
sia in grado di assicurarne la fruizione.
Tanto precisato, l’Esecutivo, al quinto comma dell’articolo in parola, ha previsto, richiamando
espressamente la disciplina dettata “ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79 [cd. Codice del Turismo], il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da
eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
Al capoverso successivo, dopo aver ribadito quanto già previsto dal Codice del Turismo in punto di
diritto di recesso bilateralmente concesso nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della
prestazione inimputabile ai contraenti, il Governo precisa che “In caso di recesso, l’organizzatore
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere
al rimborso nei termini previsti […], oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Ed ecco che, in questo modo, l’Esecutivo rende una previsione sulla quale gli interpreti hanno
instaurato un’accesa battaglia ermeneutica, arroccati sulle proprie contrapposte posizioni.
1.2 L’interpretazione letterale del DL n. 9/2020
Coloro che hanno scelto di privilegiare un’esegesi “letterale” hanno ritenuto che il testo dell’articolo
in commento riservi all’organizzatore del viaggio la scelta tra le diverse modalità di ristoro del
viaggiatore (offerta di un pacchetto alternativo, restituzione del prezzo o emissione di un voucher di
valore equivalente).
Non è difficile immaginare – ed è peraltro ciò che nel caso concreto sta accadendo – che
l’imprenditore, potendo scegliere, per far fronte alle gravi difficoltà economiche provocate
dall’emergenza sanitaria, difficilmente opterà per la restituzione al consumatore del prezzo
corrisposto per il servizio – non erogato -, preferendo uno dei rimedi alternativi.
Tuttavia una simile interpretazione si pone in aperta contrapposizione tanto con la normativa
nazionale previgente (il citato Codice del Turismo), tanto con quella sovranazionale, frustrando
finanche il perseguimento della ratio perseguita a livello comunitario, tesa alla tutela “potenziata”
delle ragioni del consumatore.
Ma siamo davvero certi che l’interpretazione letterale della normativa emergenziale testé riportata
costituisca un’interpretazione legittima?
1.3 L’interpretazione sistematica e l’interpretazione conforme
A parere dello scrivente, Il D.L. n. 9/2020 dovrebbe essere interpretato non come un atto isolato
ma, in primis, tenendo in debita considerazione la normativa in vigore e, soprattutto, nel rispetto
del diritto sovranazionale. Con riguardo alle norme emergenziali, in altre parole, se ne deve
determinare il significato in armonia con il sistema legislativo complessivo e con gli atti normativi
dell’Unione Europea.
In primo luogo va a tal fine segnalato che il citato art. 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del
Turismo), recependo fedelmente la direttiva 2008/122/CE – peraltro, come sopra già precisato,
richiamato proprio dallo stesso DL. n. 9/2020 – sancisce il diritto del viaggiatore, qualora il viaggio
divenga impossibile per causa a quest’ultimo non imputabile, di pretendere dall’organizzatore la
restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione del contratto, senza che possa essergli
imposta l’accettazione di un ristoro alternativo, unilateralmente individuato in modo discrezionale
dall’altro contraente.
Non solo. Esaminando la normativa comunitaria emerge con evidenza che la finalità che innerva la
materia in esame, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, risiedesse proprio nella creazione di
un sistema di tutela rafforzata dei diritti del viaggiatore. Vale la pena ricordare, in quest’ottica, che
l’allora Comunità Europea, mediante il ventiduesimo considerando della direttiva n. 314/90/CEE,
aveva già vietato agli Stati membri di adottare disposizioni interne più severe a danno del
viaggiatore, in materia di viaggi “tutto compreso”, consentendo soltanto l’adozione di quelle che
assicurassero a quest’ultimo un grado più elevato di tutela rispetto alla normativa comunitaria.
Ulteriore conferma dell’intento del legislatore sovranazionale giunge dalla lettura della littera legis
della direttiva 2015/2302/UE, la quale, al capo III, ribadisce, “qualora nel paese di destinazione o
nelle immediate vicinanze si siano verificate circostanze eccezionali ed inevitabili che abbiano
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del viaggio”, il diritto del viaggiatore di pretendere
dall’organizzatore la restituzione integrale del prezzo. Da ultimo, per confermare volontà degli
organi comunitari di creare un sistema di tutela rafforzata del viaggiatore, basti ricordare che la
Commissione europea, giusta comunicazione del 18 marzo 2020, nella piena consapevolezza
della situazione emergenziale dovuta all’imperversare dell’epidemia da COVID-19, ha precisato
che il diritto comunitario riserva al passeggero/consumatore, e a lui soltanto, la scelta tra il
rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.
Tanto considerato, è bene ricordare che nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti degli
stati membri dell’Unione Europea, vige il canone della “interpretazione conforme” (denominato
anche “interpretazione adeguatrice” o “interpretazione concordante”), espressione dell’obbligo di
leale collaborazione sancito dall’art. 4 TUE, in ossequio al quale la selezione del significato di una
norma avviene nel rispetto del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea sul diritto
interno. in altre parole, tra i molti significati possibili di una norma nazionale, si deve optare sempre
per quello che risponda maggiormente alle finalità perseguite dal diritto europeo, evitando ogni
possibile contrasto tra diritto nazionale e sovranazionale.
Con riferimento al caso di specie, infatti, la ragione – prima ancora che l’applicazione pedissequa
dei suesposti principi giuridici – consente di affermare che debbano prevalere l’interpretazione
sistematica e quella conforme sulla letterale.
È del tutto ragionevole, infatti, che il Governo, dapprima attraverso l’esplicito riferimento all’art. 41
del Codice del Turismo e infine mediante l’interpretazione del dettato normativo, nel rispetto della
finalità – la tutela rafforzata del viaggiatore – perseguita dal legislatore comunitario, abbia inteso
riservare a quest’ultimo la scelta in merito alle modalità di rimborso del viaggio divenuto
d’impossibile godimento.
Senza contare che la tradizionale disciplina civilistica applicabile al caso di specie, in assenza di
una normativa speciale che ne determinasse le conseguenze, giungerebbe alle medesime
conclusioni testé esposte: la parte insoddisfatta, qualora la prestazione dell’altra parte fosse
divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna di queste, potrebbe chiedere, ai sensi
degli artt. 1463 e ss. c.c., la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto già eseguito.
2. Conclusioni
Tanto argomentato in diritto, il giudice nazionale che si trovasse a dover decidere il caso di specie
avrebbe il dovere di fornire un’interpretazione dell’art. 28, comma 5, del D.L. n. 9/2020 conforme al
diritto dell’Unione Europea, riconoscendo il diritto al viaggiatore a recedere dal contratto e, qualora
quest’ultimo avesse chiesto la restituzione delle somme già pagate, pronunciando una sentenza di
condanna nei confronti dell’organizzatore del viaggio alla restituzione di tali somme.
Avv. Nicolò Tognon