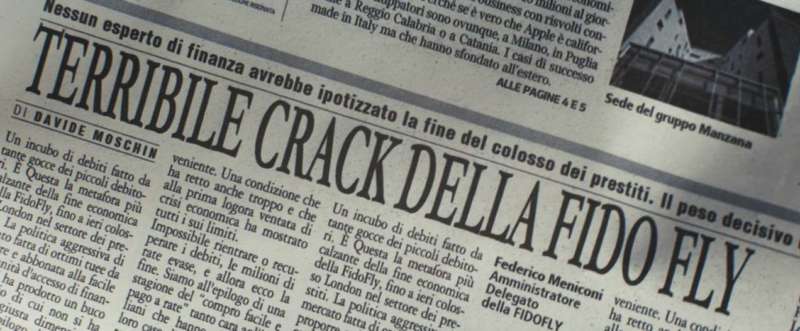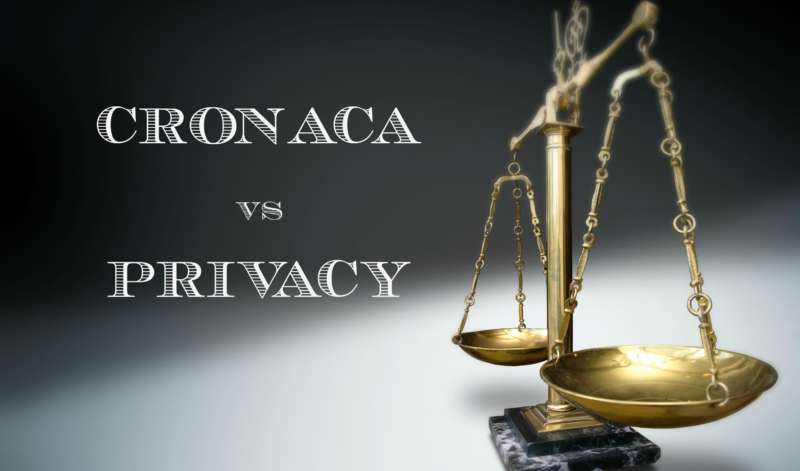Il Matrimonio al tempo del Coronavirus: la sorte dei contratti stipulati per i festeggiamenti
Nel corso degli ultimi mesi, la recente pandemia da virus COVID-19 ha danneggiato, seppur in maniera differente, ogni cittadino.
Tra i molti disagi, oltre alle tragiche e oramai note conseguenze sanitarie ed economiche, si deve considerare anche l’eventualità in cui l’epidemia – o la conseguente normativa emanata dalla Pubblica Autorità in ottica di contenimento e contrasto del contagio – abbia determinato l’impossibilità di celebrare i matrimoni – nel rispetto delle modalità concordate – per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, con inevitabile pregiudizio morale ed economico per i nubendi.
Si pensi, ad esempio, al fatto che, nella maggior parte dei casi, gli sponsali vengano festeggiati alla presenza di un gran numero di invitati, i quali celebrano il lieto momento occupando i luoghi scelti dai novizi coniugi per immortalare il momento di gioia (ristoranti, ville, parchi et similia); eventualità, questa, che, in tempi di coronavirus, non può di certo verificarsi.
Tanto premesso, viene spontaneo interrogarsi in merito alla sorte dei contratti, stipulati con i gestori dei luoghi predetti per festeggiare il lieto evento – o con le agenzie di catering preposte all’organizzazione del banchetto -, qualora il matrimonio non possa essere celebrato a causa – diretta o indiretta – della pandemia da COVID-19: in particolare, i nubendi potranno sciogliersi dal vincolo così contratto e ottenere la restituzione delle eventuali somme versate a titolo di acconto sul prezzo del servizio?
Al fine di rispondere compiutamente al quesito testé esposto, occorre indagare la disciplina di due diversi istituti che, in ogni caso, conducono alle medesime conclusioni.
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. per intervento del cd. factum principis.
In primo luogo, è sempre bene premettere che l’impossibilità di celebrare il matrimonio – e conseguentemente festeggiare i nubendi – per effetto dell’intervento dei provvedimenti della Pubblica Autorità (resi per fronteggiare il dilagante imperversare della pandemia) rientra a pieno titolo nella nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione per intervento del factum principis.
Come già ampiamente chiarito nel corso delle precedenti pubblicazioni, tali sono considerati tutti quegli atti della Pubblica Autorità che, perseguendo il pubblico interesse, impongano o vietino determinati comportamenti, sopprimendo individuate libertà personali.
La normativa d’urgenza, tuttavia, può integrare una causa d’impossibilità della prestazione non imputabile al debitore solo allorché quest’ultima non sia a lui soggettivamente rimproverabile, essendo pertanto necessario che sia connotata dai tratti dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità per un debitore diligente al momento del sorgere dell’obbligazione.
In altre parole, perché possa applicarsi la disciplina in esame, è necessario che il debitore non si sia in alcun modo potuto avvedere dell’imminente emanazione di simili provvedimenti.
Nel caso di specie, pertanto, deve senz’altro ritenersi che i nubendi che abbiano stipulato con i suddetti gestori e organizzatori, in tempi non sospetti e antecedenti alla declaratoria della nota pandemia, i contratti volti all’erogazione dei relativi servizi, non potessero di certo prevedere la situazione che si sarebbe in seguito verificata nel periodo corrispondente alla celebrazione del proprio matrimonio.
Del pari, è altrettanto certo che i nubendi non possano usufruire, nel periodo di vigenza dei provvedimenti della Pubblica Autorità, della prestazione offerta dagli organizzatori dell’evento, a causa delle limitazioni imposte dai provvedimenti emergenziali.
Se è pacifico che l’inadempimento della propria obbligazione contrattuale posto in essere dall’organizzatore dei festeggiamenti debba considerarsi incolpevole, in considerazione della sopravvenuta impossibilità della prestazione che ne è oggetto, a norma degli artt. 1176, 1218 e 1256 c.c. – conseguentemente non potendo essere tenuto a risarcire il connesso danno cagionato al creditore -, è ragionevole ed equo ritenere che anche la parte insoddisfatta non possa essere obbligata a corrispondere la controprestazione.
Ciò in quanto, pur in presenza di un’impossibilità della prestazione inimputabile a ciascuna delle parti, qualora fossero sorte dal negozio prestazioni corrispettive non si potrebbe di certo pensare che il creditore di una siffatta prestazione fosse tenuto ad adempiere la propria obbligazione senza, a sua volta, ricevere la dovuta controprestazione.
Non resta quindi che applicare la disciplina prevista dal Codice Civile, agli artt. 1463 e ss., in materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, a norma della quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia’ ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
Nell’ipotesi in esame, pertanto, i nubendi, parti insoddisfatte, potranno chiedere, ai sensi degli artt. 1463 e ss. c.c., la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e l’eventuale restituzione di quella già eseguita (rectius, delle somme già corrisposte a titolo di acconto sul prezzo complessivo del servizio).
- La presupposizione
In ogni caso, la fattispecie in esame lascia spazio all’applicazione, alternativa o in via subordinata, di un altro istituto civilistico che, partendo da presupposti dogmatici differenti, consente agli sfortunati innamorati di beneficiare del medesimo grado di tutela.
Tale è la cd. Presupposizione, la cui disciplina non è rinvenibile nel codice civile ma è stata elaborata dalla dottrina italiana a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, sulla falsariga dell’analogo istituto di matrice tedesca.
La Suprema Corte, applicando gli studi dottrinali testé citati, lo ha definito, a più riprese, alla stregua di “quell’avvenimento futuro e incerto, taciuto dalle parti ma dato per presupposto, da cui dipende l’efficacia del contratto stesso” (si veda, ex multis, Cass. n. 12235/2007), riconoscendone l’oramai indiscussa operatività nel nostro ordinamento (a conferma, Cass. n. 15025/2013).
In altre parole, per presupposizione si intende quella condizione non sviluppata – o quel presupposto non dichiarato dalle parti – il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall’attività e dalla volontà dei contraenti.
Tuttavia, dalla sussistenza e dalla verificazione di tale implicito presupposto dipende l’efficacia stessa del contratto, giacché ritenuto per le parti stesse indispensabile ai fini della proficua realizzazione degli scopi contrattuali.
Tanto argomentato in diritto, la fattispecie in esame sembra proprio rappresentarne il classico caso di scuola.
Si noti, infatti, che il contratto di servizio stipulato con l’organizzatore del banchetto di matrimonio (o con il gestore della Villa, scelta dai nubendi quale teatro dei festeggiamenti) trova il proprio presupposto e realizza la propria finalità solo nel caso in cui la celebrazione e i festeggiamenti si tengano entrambi nel periodo concordato.
In tal caso, se – com’è peraltro accaduto nella maggioranza dei casi – i festeggiamenti venissero rimandati perché vietati, con le modalità pattuite tra le parti, dalla normativa d’urgenza emanata per contrastare la pandemia, il contratto perderebbe di efficacia.
Ciò in quanto è evidente che entrambe le parti, al momento della stipula del contratto de quo, potevano dirsi consapevoli, pur non avendolo esplicitato nelle clausole negoziali, che esso fosse stipulato subordinatamente all’evento in questione.
Nel caso in cui operi la presupposizione, pertanto, quali sono i rimedi esperibili dai nubendi insoddisfatti?
Sul punto dottrina e giurisprudenza sono giunte a conclusioni differenti ma dagli effetti pratici simili.
Il pensiero dottrinale si è servito del disposto dell’art. 1366 c.c., a mente del quale il contratto va interpretato secondo buona fede, ravvisando in esso il principio generale da cui discende l’istituto della presupposizione.
Infatti, considerata la consapevolezza in capo alle parti dell’importanza che il particolare presupposto riveste nel complessivo assetto di interessi alla cui realizzazione è teso il contratto, sarebbe contrario a buona fede pretendere l’adempimento anche dopo il venir meno del presupposto stesso.
Pertanto, la prestazione del contraente insoddisfatto diverrebbe inesigibile.
La giurisprudenza, invece, servendosi dell’istituto della presupposizione giunge a conclusioni identiche a quelle a cui conduce l’applicazione dell’art. 1463 c.c., confermando la correttezza, dal punto di vista giuridico, del rimedio individuato.
Se infatti – come accade nel caso di specie – l’oggetto avesse perso di interesse per uno dei contraenti (diviene impossibile celebrare e festeggiare il matrimonio con la totalità degli invitati a causa delle misure governative) l’orientamento giurisprudenziale in parola permetterebbe il ricorso all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta e, in ogni caso, a quello dell’inesigibilità secondo il criterio della buona fede ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.
Pertanto, i nubendi potranno anche in questo caso chiedere la risoluzione del contratto e resistere alla pretesa dell’altra parte volta all’ adempimento della controprestazione, oltre a pretendere da quest’ultima la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a titolo di acconto.
- Conclusioni
In conclusione, quale sia l’istituto che si decida di applicare (risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc o presupposizione), sarà possibile per i nubendi resistere alla pretesa dell’altra parte di adempimento della controprestazione – perché contraria a buona fede -, chiedere la risoluzione del contratto e pretendere altresì la restituzione delle somme eventualmente corrisposte all’organizzatore o al ristoratore a titolo di acconto sul prezzo complessivo.
Avv. Nicolò Tognon